
La crisi climatica ci pone sicuramente ad un bivio dinnanzi al consumo di carne. Secondo Project Drawdown, una piattaforma che raccoglie soluzioni pratiche (moderate) ai cambiamenti climatici, una dieta ricca di verdure sarebbe la terza soluzione più impattante per contenere il riscaldamento globale a 2°C rispetto ai livelli preindustriali entro il 2100 [1].
La tipica risposta dell’industria, messa alle strette, è quella di cambiare tutto senza cambiare niente. In particolare si presentano due strade: quella del passato nostalgico a cui ritornare (gli allevamenti “come una volta”) e quella del futuro possibile, da costruire, grazie al genio umano e al suo multiforme ingegno. Sono queste due vie quelle che ormai nel mondo antispecista chiamiamo “bioviolenza bucolica” e “bioviolenza 2.0”.
Sono due strade ugualmente problematiche, anche se per motivi diversi. Partiamo dalla prima.
Nonostante gli allevamenti estensivi siano visti come un qualcosa di auspicabile anche da parte di alcune frange animaliste, la “bioviolenza bucolica” rappresenta una questione decisamente più spinosa rispetto al modello “tecnocratico”. Centrale nel promuovere questo tipo di allevamenti è la questione del benessere animale: negli allevamenti bio, slow e green gli animali sarebbero curati, accuditi e potrebbero svolgere le loro abitudini etologiche. Si riconosce quindi che gli animali non umani possano soffrire e si tende a evitare questa sofferenza fornendo agli animali spazi e strutture adeguati, un’alimentazione corretta, cure e farmaci tendenzialmente naturali. Tutto ciò, però, avviene sotto l’egida di una grande contraddizione: se si riconoscono gli animali come soggetti che non devono soffrire, com’è possibile accettare che possano invece essere uccisi? Ci sono altre questioni che potrebbero essere sottolineate: per esempio come il benessere animale sia economicamente conveniente in quanto la carne delle vittime degli allevamenti viene venduta a un prezzo premium; oppure come proporre gli allevamenti estensivi come modello di allevamento virtuoso sia estremamente elitario in quanto i prezzi elevati che propongono escludono le fasce meno abbienti e quindi, necessariamente, non propone un modello applicabile globalmente; o ancora si potrebbe dire che se fosse applicabile globalmente servirebbero troppe terre per poterlo realizzare. Tuttavia, queste questioni sono secondarie rispetto al fatto che è proprio il tema del benessere animale il traino e la forza delle aziende che propongono i modelli estensivi ed è proprio questa fiducia nel benessere garantito che rende per moltə consumatori e consumatrici giustificabile il mangiare animali. È paradossale, però, immaginare individui capaci di soffrire e il cui benessere debba essere tutelato, ma poi escludere che anche vivere possa essere tra i loro interessi. La bioviolenza bucolica plasma quindi delle creature alquanto inusuali: individui che avrebbero tra i propri interessi biologici l’evitamento del dolore, ma la cui vita, libertà e autodeterminazione hanno comunque un valore secondario. Addirittura – e su questo punto torneremo ancora in seguito – la vita avrebbe un valore secondario rispetto alla garanzia di una seppur breve umana protezione dalle insidie del mondo “esterno”.

È da questa narrazione sul benessere come unico fine degli animali che fioriscono tutta una serie di schiavitù: gli allevamenti, come abbiamo visto, ma anche gli zoo o meglio i bioparchi, dove le scenografie suggestive e gabbie dorate senza predatori fanno credere ai visitatori e alle visitatrici che gli animali stiano bene, dove appunto “stare bene” è sinonimo di non provare dolore. E con questa retorica del benessere garantito ci siamo scontratə anche noi durante la nostra campagna per gli orsi rinchiusi nel Casteller. Stanno bene, secondo le amministrazioni, come se stare “fisicamente bene” fosse in qualche modo prioritario dinnanzi alla prospettiva di una vita circondati dal cemento (e comunque, per la cronaca, filmati e dichiarazioni di veterinari hanno smentito più volte le amministrazioni su questo presunto benessere). E sarebbero andati a stare bene, invece, per tuttə quellə attivistə che proponevano la deportazione degli orsi in questo o quel parco lontano dal Trentino, come se gli orsi fossero oggetti da poter spostare a nostra discrezione, ma soprattutto come se la questione del trasferimento degli orsi non aprisse una questione politica più grande sulla libertà, su chi ha diritto di attraversare i territori o sull’antropizzazione.

In contrapposizione a tutta la narrazione del benessere vi è invece la bioviolenza 2.0. Il “passato come una volta” lascia spazio alla tecnocrazia e alla creazione di nuovi mercati. La questione della crisi climatica, con cui abbiamo aperto questa riflessione e che è centrale nel progettare gli allevamenti del futuro, non sarebbe nient’altro che una grandissima opportunità su cui investire, nonché le basi che fondano l’economia della riparazione.
Uno degli strumenti per questa nuova economia sono i meccanismi di offsetting o di compensazione. Cosa siano questi meccanismi ce lo chiarisce una storia molto nota, quella dei guai di Coca-Cola in India. Nel 2004, la Coca-Cola è stata costretta dalle autorità del Kerala a chiudere i suoi impianti dopo lunghe proteste a causa del prosciugamento delle falde acquifere locali causato proprio dalla presenza della multinazionale; nel 2014 il governo indiano nega alla Coca-Cola la possibilità di espandere il suo impianto nello stato del Varanasi; nel 2015 proteste di massa portano il governo indiano a ritirare la concessione per un impianto di imbottigliamento nel Tamil Nadu. Nulla di strano se non che, da anni, Coca-Cola dichiara di essere water neutral. Come si fa quindi a essere water neutral o, in altri casi, carbon neutral? Finanziando un progetto di efficienza idrica qui e là per esempio. Quindi anche se prosciugando le falde acquifere in Kerala posso essere comunque sostenibile se supporto allo stesso tempo un progetto in Sudan. Posso essere carbon neutral se sono una compagnia aerea che vive di petrolio, ma pianto alberi in Messico, e così via. Inquino da un lato, ma riparo (forse) qualcosa dall’altro, come se le popolazioni locali, umane e non umane, e la vegetazione possano essere interscambiabili in un gioco a somma zero.

Vi è proprio un mercato di questa neutrality, dove grandi multinazionali e privati possono acquistare crediti per compensare le proprie emissioni. E qui il colpo di scena: dal 2021 in questo grande “mercato del nulla” è possibile acquistare anche scorregge e rutti di mucca. O meglio, scorregge e rutti di mucca non emessi. Molti di noi sanno che i bovini sono responsabili di emissioni di metano enterico e che il metano è un gas serra – e quindi che gli allevamenti inquinano. Un’azienda svizzera ha quindi inventato il Mootral, un integratore che riduce le emissioni dei bovini. Grazie al Mootral gli allevamenti possono dire di essere più sostenibili (come se oltre alle emissioni non ci fossero problemi di deforestazione, consumo d’acqua, ecc…). Questo è un capolavoro del capitalismo perché da un lato abbiamo la tecnologia, che ci fa affermare che l’allevamento sostenibile sia possibile, dall’altro abbiamo la nascita di nuove formule di speculazione capitalistica, ovvero gli allevatori che non solo lucrano sulle loro mucche, ma lucrano pure sul metano non emesso per venderlo sotto forma di credito di carbonio.
La crisi diventa un’opportunità e quindi si può estrarre più valore da quello che inizialmente sembrava un problema.
Un altro esempio di speculazione multipla sugli animali degli allevamenti sono le mucche che diventano una fonte di energia. Infatti, uno dei modi più comuni per creare nuove forme di accumulazione dalle mucche è quello di investire su impianti di biogas che raccolgono il metano dai liquami. Il metano raccolto viene poi usato come fonte di energia (e qui c’è la seconda forma di speculazione – la prima è ovviamente la trasformazione dell’animale in prodotto). Vi è inoltre una terza forma di speculazione: la combustione del metano diminuisce il suo potenziale riscaldante (rispetto al metano “libero”), perché quel metano, una volta bruciato, si trasforma in due molecole d’acqua e in una di anidride carbonica. Quindi che cosa succede? Non solo si produce energia, ma diminuisce l’emissione di gas serra. E che cosa succederà a questi gas non prodotti? Saranno venduti alle grandi aziende che inquinano per compensare le loro emissioni. Anche chi non è ferocemente anticapitalista qui vedrà la grande truffa. Si spaccia per energia pulita un’energia che si basa comunque sulla deforestazione, sul consumo di acqua, sul consumo di risorse…
La nostra fede nella tecnologia – unita alla nostra convinzione di essere semidivinità – ci fa, infine, approdare sulle spiagge della manipolazione dei corpi. Se quei corpi animali non sono sostenibili, allora possiamo renderli tali: si possono creare polli senza piume affinché si possa risparmiare acqua nell’operazione di spiumaggio; mucche con particolari capacità di termoregolazione corporea affinché non patiscano gli stress climatici; mucche nane che con le loro ridotte dimensioni si adattino a contesti di autoproduzione e, soprattutto, consumino meno risorse e emettano meno CO2 in confronto alle loro sorelle più grandi, producendo proporzionalmente più latte e carne; oppure si possono creare, attraverso la selezione genetica, mucche da carne grandissime, che quindi abbiano una resa molto maggiore per carne. La Belgian Blue, per esempio, è una mucca così grande che partorisce quasi esclusivamente con il cesareo.

L’unico limite della bioviolenza è la fantasia. Non si creano solo tante nuove forme di accumulazione e mercificazione quante è possibile pensarne, ma, addirittura, si progettano animali affinché soddisfino particolari requisiti etici: mucche senza corna affinché non debbano essere sottoposte alla procedura dolorosa di decornazione (pratica eseguita per prevenire i danni che queste potrebbero provocare alle loro compagne di sventura negli spazi angusti degli allevamenti intensivi e soprattutto per disarmarle del loro unico strumento di difesa contro gli allevatori); maiali con testicoli che non si sviluppano per evitare che questi debbano essere castrati senza anestesia (pratica eseguita perché i maiali castrati hanno una carne qualitativamente superiore per il mercato); infine, ritorna ciclicamente l’idea di causare una disabilità agli animali per migliorare il loro benessere, come per esempio creare galline cieche affinché, sotto stress, becchino meno efficacemente le loro compagne (il cannibalismo è una questione ordinaria negli allevamenti intensivi) o, addirittura, animali incapaci di soffrire per risolvere rapidamente la questione se sia etico fare del male a un animale in grado di provare dolore.
Se creare disabilità ad animali per migliorare la loro produttività può sembrare orrifico, in realtà l’industria zootecnica è per natura un apparato disabilizzante: mucche con mammelle troppo grosse, tacchini e polli che non riescono a sostenere il peso dei loro petti giganteschi e pesantissimi, maiali con problemi articolari dovuti al peso… Per gli animali degli allevamenti intensivi alle disabilità fisiche si aggiungono poi quelle indotte dalla vita in un ambiente malsano, sporco e affollato.
Lə studiosə di Critical Animal Studies e di Disability Studies hanno spesso messo in relazione come siano diversi e sfaccettati i legami tra l’oppressione di animali non umani e l’oppressione di persone disabili. Ci si potrebbe soffermare sul fatto che l’industria zootecnica produca sistematicamente disabilità negli animali e, più invisibilmente, nei lavoratori che utilizzano macchinari pericolosissimi, oppure che giustificare la minor considerazione morale degli animali con un discorso su una (presunta) intelligenza inferiore definisca anche quale sia la reale considerazione morale degli individui umani con disabilità cognitive. Tuttavia, volendo approfondire qui le diverse narrazioni della bioviolenza e di come queste siano profondamente intersecate con l’abilismo, ci si soffermerà in particolare sulla questione della cura.
Come scrive Sunaura Taylor nel suo capolavoro Bestie da soma: «Per molti versi l’ideologia che sostiene il movimento della carne felice è una filosofia costruita sull’idea dell’interdipendenza. Gli animali domestici e gli esseri umani si sono evoluti insieme per essere interdipendenti: gli animali aiutano gli esseri umani, e noi a nostra volta aiutiamo gli animali, o almeno così si sostiene. Le teorie sull’interdipendenza del movimento della carne felice, tuttavia, ricompensano tuttora l’indipendente a scapito dei dipendenti, e il più forte a scapito dei più vulnerabili. […] Il contributo della disabilità alla discussione sulla carne felice è l’analisi necessaria di ciò che significa essere responsabili nei confronti di chi è vulnerabile» (Taylor 2021: p. 260).
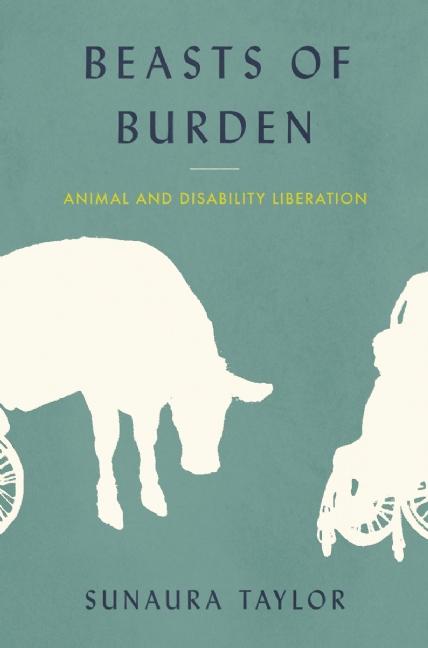
Le prospettive offerte dai Critical Disability Studies ci permettono quindi di rispondere a una delle contraddizioni della bioviolenza “bucolica”, ovvero che la vita di individui vulnerabili abbia un valore minore rispetto alla protezione ricevuta e che questa protezione debba essere pagata con la stessa vita.
La prospettiva intersezionale ci permette anche di osservare con una lente più critica anche altri aspetti della questione animale. Come Assemblea Antispecista siamo nat rispondendo alla richiesta di aiuto di un orso che per tre volte era fuggito dalla sua prigione. Non siamo riuscitə a ignorare un atto così potente di Resistenza Animale, un tale e potente esempio di un individuo non umano che voleva autodeterminarsi nonostante i suoi oppressori avessero deciso che la sua libertà dovesse essere negata.
Come collettivo, abbiamo cercato subito alleanze con i movimenti ecologisti. La nostra lotta con gli orsi (e non per gli orsi!) era anche la lotta di un movimento contro l’antropizzazione degli spazi, un movimento in cui tutto il non umano (sia esso animale o vegetale) viene cancellato o ridotto a mero oggetto da utilizzare a fini umani. E così è stato per gli orsi: quando il loro ruolo di mascotte del turismo si è scontrato con gli interessi di allevatori, cacciatori e amministrazioni incapaci anche tutti i bei discorsi sulla biodiversità legati alla reintroduzione di questi animali è andato svanendo. Se appare quindi chiaro che un movimento di lotta con gli orsi che resistono trovi come alleato naturale un movimento anticapitalista contro la mercificazione della natura, tuttavia, sono di nuovo i Critical Disability Studies a offrire le prospettive più interessanti sulla resistenza animale.
L’atto di resistenza di M49, la sua fuga, per ben 2 volte dalla prigione del Casteller, è stato forse l’atto più eclatante di resistenza animale avvenuto, almeno in tempi recenti, nel panorama italiano. La resistenza animale, però, avviene quotidianamente e la zootecnia stessa è una storia della resistenza animale: i recinti, i gioghi, le briglie, il morso, le pratiche di mutilazione quali la rimozione delle corna dei bovini, delle zanne dei maiali e la sterilizzazione degli individui più aggressivi e infine la selezione genetica sono testimonianze storiche del fatto che gli animali non siano mai stati complici inermi dei loro sfruttatori quanto piuttosto siano individui che lottano e che hanno sempre lottato. Tuttavia, le fughe di animali, alcune durate anche mesi, vengono sempre ricondotte ad atti istintivi, a incidenti o, nelle situazioni migliori, a eventi folcloristici. M49, invece, con le sue fughe ripetute fa crollare una qualsiasi narrazione in cui la resistenza animale sia un atto accidentale e si scontra con quell’idea, purtroppo diffusa anche in ambito animalista, che gli animali siano senza voce o senza agency. In queste narrazioni, gli animali non sono visti come agenti ma, nella migliore delle ipotesi, si riconosce solo la loro sofferenza. La negazione della capacità di autodeterminarsi e la riduzione della propria persona a mero individuo che soffre è una denuncia che spesso le persone disabili muovono alla società abilista e alle stesse associazioni che si definiscono in difesa dei loro diritti. Essere “senza voce” – oltre che essere una caratterizzazione che tristemente molti gruppi animalisti fanno dei non umani – è un tratto che definisce quasi sempre le persone con disabilità cognitive. Come scrive Sunaura Taylor, considerare gli animali senza voce tradisce il pregiudizio abilista di cosa sia e cosa non sia voce. Ritenere che gli animali non abbiano una voce equivale ad avere una concettualizzazione estremamente ristretta di cosa voglia dire comunicare. Gli animali, al contrario, parlano e lo fanno attraverso i gesti, le posture, le espressioni facciali, odori che non sempre sentiamo e suoni che non sempre riconosciamo, ma soprattutto lo fanno attraverso le loro fughe, i loro atti di ribellione. Come scrive Hribal, storico della resistenza animale, nel suo saggio Animals, Agency, and Class: Writing the History of Animals from Below, l’asino che non ubbidisce ai comandi, il bue che si rifiuta di lavorare, il cavallo che distrugge l’attrezzatura, i polli che hanno beccato le mani del fattore, le mucche che scalciano, i maiali che fuggono dalle recinzioni, le capre che le saltano sono tutti atti di resistenza e sono tutti atti che dimostrano che gli animali abbiano una voce che noi, però, non ascoltiamo.
Non sono solo i Critical Disability Studies a offrire nuove chiavi di lettura sull’antispecismo, ma generalmente l’approccio intersezionale ci permette di arricchire il mettere in luce come le diverse oppressioni interagiscano tra di loro.
[1] Le prime due soluzioni sono ridurre gli sprechi alimentari (la prima) e l’istruzione e il family planning (la seconda).
