
Il concetto di intersezionalità nasce nell’ambito del femminismo nero e in particolar modo dall’esigenza di mettere in luce come le diverse oppressioni interagiscano tra di loro. Nel 1989 Kimberlé Crenshaw, docente universitaria, pubblica un paper in cui tratta come una donna nera subisca contemporaneamente razzismo e maschilismo, e come le due oppressioni non siano “sezioni” scindibili, ma categorie che interagiscono continuamente. A partire dal fondamentale lavoro di Crenshaw è divenuto sempre più chiaro il legame indissolubile tra le diverse oppressioni, legate tra loro da quella matrice comune che vede da una parte un sistema oppressivo (ad es. il razzismo) perpetrato da chi porta con sé un privilegio (ad es. la bianchezza) e dall’altro la classe oppressa (ad es. le persone razzializzate) che non è portatrice di quel privilegio (ad es. bianchezza vs. nerezza). Così come vi è una matrice comune nelle dinamiche di oppressione, dovrebbe esserci una matrice comune anche nelle dinamiche di lotta e di liberazione, per cui la liberazione non dovrebbe essere a sua volta trattata come un percorso a “sezioni”, bensì come un qualcosa di totale, che tocchi tutte le classi marginalizzate, verso le quali dovremmo porci come complici. Il riconoscimento e la decostruzione del proprio privilegio è un lavoro complicato e per niente scontato, ma fondamentale affinché si possa parlare di liberazione, resistenza e complicità. Fra questi, il privilegio che tendenzialmente più fatichiamo a riconoscere, perché totalizzante e spesso invisibilizzato, è il nostro privilegio di specie. La specie umana impone da migliaia di anni il proprio dominio sulle altre specie animali, considerate di per sé inferiori e quindi schiavizzabili, sfruttabili e sacrificabili: il sistema oppressivo sarà quindi lo specismo (termine coniato sul calco di tutti gli altri -ismi) perpetrato dall’homo sapiens, portatore di un privilegio di specie, contro gli animali non umani tutti, privi di quel privilegio.

In Carne da macello. La politica sessuale della carne. Una teoria critica femminista vegetariana, Carol J. Adams mette in luce lo stretto legame che vi è tra maschilismo e specismo, e in particolar modo tra cultura patriarcale e cultura della carne: il consumo dei corpi degli animali non umani, così come quello dei corpi femminili, è retaggio di una cultura profondamente patriarcale. Il consumo della carne e quello sessuale diventano possibili creando quello che Adams chiama “referente assente”, ovvero l’individuo che sta dietro al pezzo di carne, sia esso inteso letteralmente o metaforicamente; in questo modo il carnivoro e il maschilista può continuare a perpetrare le proprie violenze con la coscienza pulita. Dovremmo riconoscere il legame indissolubile tra maschilismo e specismo ogni qual volta una donna viene chiamata “troia”, “scrofa”, “maiala”, “porca”, “cagna” o “vacca”, e quindi mortificata attraverso l’animalizzazione. Si tratta di una dinamica che parte dall’idea che la donna, così come l’animale non umano, sia inferiore rispetto all’essere umano con la E maiuscola: il maschio. Così come le femmine umane subiscono oggettivazione sessuale, le femmine non umane vengono oggettivate alla stregua di macchine negli allevamenti: una mucca in un allevamento non è più un individuo che si autodetermina, ma un corpo da cui estrarre plusvalore attraverso abusi sessuali, gravidanze costrette, privazione delle figlie (destinate a ricoprire il loro stesso ruolo) e dei figli (destinati al macello), allattamento forzato e una morta prematura. Il tutto, ça va sans dire, senza quello che per il femminismo è uno dei punti chiave: il consenso.
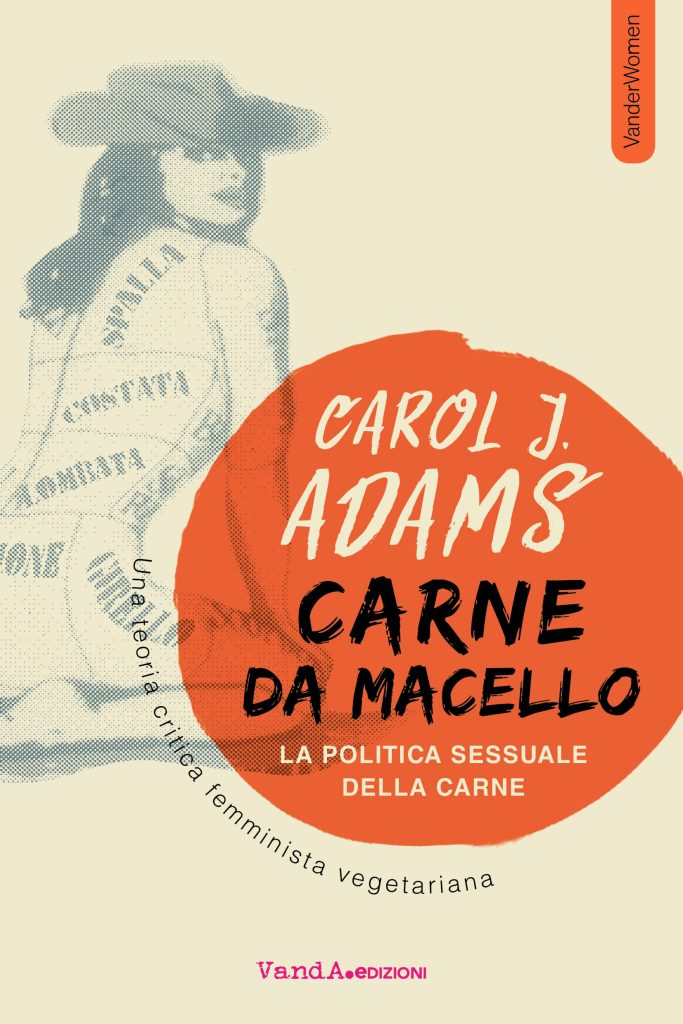
Oltre al testo di Carol J. Adams, tutt’ora fondamentale, ma invero un po’ datato, altre due autrici che hanno trattato il tema in modo molto esaustivo sono Aph e Syl Ko in Afro-ismo. Cultura pop, femminismo e veganismo nero. Le due sorelle afro-discendenti spiegano la natura dello stretto legame tra femminismo, veganismo (e antispecismo) e anti-razzismo, tassello quest’ultimo già anticipato da Adams, ma approfondito una volta per tutte dalle sorelle Ko. Le persone nere, così come tutte le persone razzializzate, fanno parte di una classe marginalizzata e svantaggiata, così come le donne e gli animali non umani: ce ne rendiamo conto quando per mortificare una persona nera la chiamiamo “bestia” o “scimmia”, ce ne dovremmo rendere conto ogni qualvolta vediamo un animale rinchiuso in una gabbia, legato a una catena, piegato sotto una frusta, costretto al giogo e a estenuanti ritmi di lavoro. Per questo, scrivono le sorelle Ko, le persone nere dovrebbero smetterla di chiamare gli sbirri “maiali”: i maiali resistono al dominio umano come le persone razzializzate resistono a quello delle persone bianche occidentali. Lo stesso vale per i fascisti, a cui alludiamo come se fossero ratti ogniqualvolta diciamo loro di tornarsene nelle fogne. Il fatto di essere persone marginalizzate per il colore della pelle o per l’estrazione politica non ci rende immuni dall’essere a nostra volta oppressori: parlare di sbirri-maiali e di fascisti-ratti non è poi così diverso da parlare di comunisti-zecche, lo specismo persiste, il sistema delle forze dell’ordine o quello fascista diventano semmai l’aggravante.
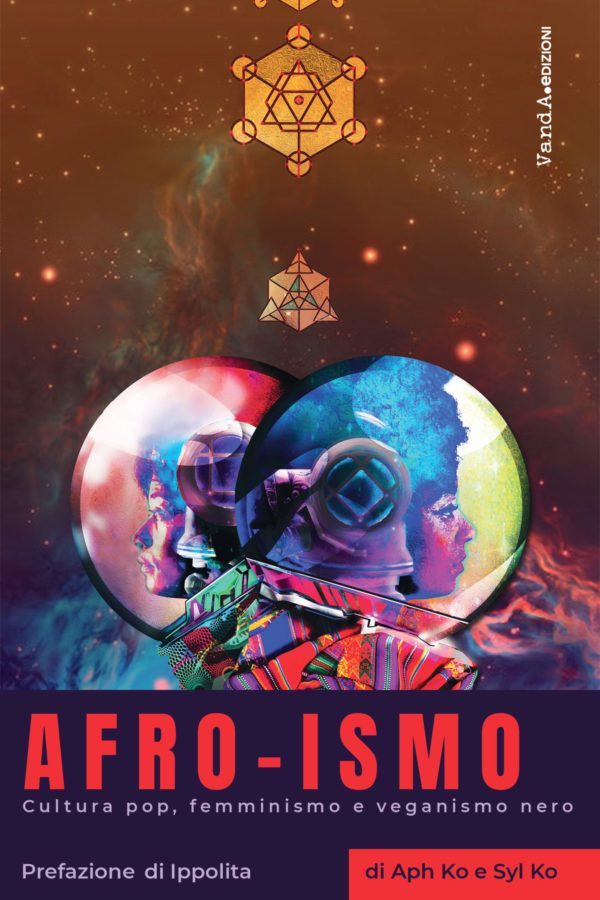
In Manifesto Queer Vegan Rasmus Rahbek Simonsen, vegano queer, mette in luce i punti di intersezione tra il coming-out come persona queer e quello come persona vegana: si tratta in entrambi i casi di azioni perturbanti, capaci di mettere in crisi la tradizionale famiglia raccolta intorno a una tavola. In ambiente anglofono il ragazzo che noi, per usare un termine maschilista, chiameremmo “effemminato” prende il nome di soy boy: la soia è un alimento per persone vegane e quindi per “femminucce”, i veri maschi, quelli virili, eterosessuali e cisgender, mangiano la carne. Si nota in questo caso l’intersezione tra queerfobia, antispecismo e vegefobia, ovvero la marginalizzazione delle persone vegane. La non-conformità alla norma eteropatriarcale, soprattutto quando coincide con un corpo non conforme, indecoroso e da nascondere (come può essere ad esempio quello di una persona transgender), coincide con la non-conformità alla norma specista, per cui anche quegli degli animali non umani sono corpi non conformi, indecorosi e da nascondere: non vogliamo avere nulla a che fare con loro e li releghiamo nelle strade, nelle periferie, negli allevamenti e negli zoo, per poi eventualmente renderli oggetto delle nostre perversioni.
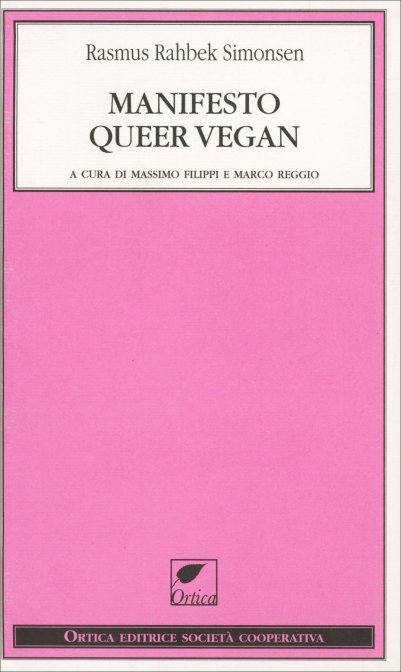
Ma la non-conformità non è solo quella dei corpi non-maschili, non-bianchi, non-cisetero: la non-conformità è anche quella dei corpi e delle menti disabili. È uscita recentemente la traduzione italiana di Beasts of Burden. Animal and Disability Liberation (Bestie da Soma. Disabilità e Liberazione Animale) di Sunaura Taylor: si tratta di un testo fondamentale per quanto riguarda l’intersezione tra abilismo e specismo, che Taylor conosce molto bene, essendo lei stessa una persona disabile e animalizzata sin da piccola. La stessa Taylor ammette che la lista di esempi che si potrebbero fare a tal proposito è infinita e ricorda il caso di Elephant Man: il fatto che la filariasi linfatica venga più spesso chiamata elefantiasi o pachidermia acquisita rende già conto di quanto sia stretto il legame tra abilismo e specismo, ma Taylor ricorda in particolar modo la scena del film in cui John Merrick grida: «Non sono un animale!». I freaks d’altronde sono persone disabili e non conformi che vengono tradizionalmente esposte al pubblico pagante non diversamente da come si fa con gli animali non umani in zoo e circhi. Un altro aspetto dell’intersezione tra abilismo e specismo riguarda il fatto che per velocizzare ed economizzare la catena di (s)montaggio negli allevamenti gli animali non umani vengono letteralmente resi disabili: le mutilazioni sono la norma del mercato, anche quello più “sostenibile”, sia alimentare (castrazione, sbeccamento, rimozione di denti, ali, code, corna, ecc…), che non (rimozione delle ali nei volatili pet, taglio di orecchie e coda nei cani, ecc…). Le nuove biotecnologie puntano a creare animali già mutilati, così da guadagnarci in tempo e manodopera, o addirittura non senzienti. Le nuove biotecnologie hanno creato razze di animali con disabilità così gravi da non poter sopravvivere liberi: basti pensare ai polli broiler, destinati a spezzarsi sotto il loro stesso peso. Ma di questo ne abbiamo già parlato ampiamente nell’articolo dedicato alla bioviolenza e alla resistenza animale.
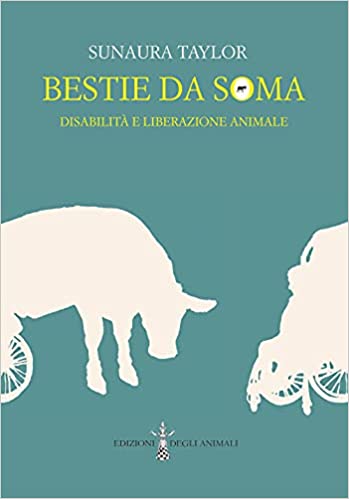
Non ci stupisce, insomma, che John Merrick gridasse: «Non sono un animale!». Nessunə vuole essere trattatə come un animale, però questo dovrebbe portarci a mettere in discussione non solo il modo in cui veniamo trattatə noi, ma anche il modo in cui vengono trattati gli animali non umani.
